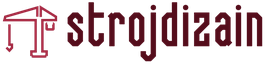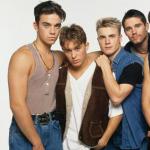Hartmann privo di sensi. Enciclopedia dell'esoterismo moderno
A fine del XIX secolo maggiore scetticismo. La verità, secondo Nietzsche, è "una specie di errore". La negazione di un principio e di una verità superiori diede origine all'irrazionalismo. Il rifiuto dell'onnipotenza hegeliana della logica ha portato alla filosofia dell'inconscio Edward Hartmann(1842-1906).
L'inconscio, secondo Hartmann, è un'unica sostanza spirituale comune alla natura e alle persone e alla base delle loro attività. Nell'uomo, l'inconscio opera a livello dell'istinto, che non sbaglia mai. Il concetto di inconscio non è esclusivo della cultura occidentale. Nell'antica filosofia indiana vi si prestava molta attenzione, sia per le motivazioni subconsce che per la supercoscienza, che era intesa come una parte di un essere umano che è in contatto con l'Uno.
Hartmann ha continuato Kant e soprattutto Schopenhauer nel senso che attaccavano al testamento. Alla volontà cosciente Hartmann aggiunse la volontà inconscia, che secondo lui è primaria e più forte.
Una delle proprietà dell'inconscio è l'azione istantanea. Se facciamo qualcosa senza pensare, al primo impulso, questa è la manifestazione della volontà inconscia. Può essere in conflitto con i desideri coscienti, e questo spiega lo stato in cui capiamo con la mente cosa deve essere fatto, ma qualcosa dentro, incomprensibile per noi stessi, ci impedisce di iniziare a realizzare ciò che abbiamo pianificato e facciamo qualcosa di completamente diverso. Con l'aiuto dell'idea della volontà inconscia, si può spiegare perché il piacere spesso si trasforma nel suo opposto. L'uomo si abbandona all'istinto, che è l'espressione della volontà inconscia. Ma dopo la sua soddisfazione, quest'ultima si indebolisce, ma la volontà cosciente, insoddisfatta di ciò che è accaduto, si rafforza; da qui il sentimento di insoddisfazione per se stessi.
Concludendo che la non esistenza del mondo merita la preferenza sul "folle carnevale dell'essere", Hartmann getta un ponte nella filosofia del 20° secolo.
domande di prova
1. Quali sono le caratteristiche principali della filosofia del XIX secolo.?
2. Come si rapporta la filosofia di Fichte, Schelling e Hegel alla filosofia di Kant?
Quali sono le somiglianze e le differenze tra la filosofia di Schelling e quella di Hegel?
Quali sono le leggi fondamentali della dialettica hegeliana?
Qual è l'Idea Assoluta?
Quali sono le somiglianze e le differenze tra i sistemi di Hegel e Aristotele?
Come immaginava Comte l'evoluzione della cultura umana?
Quali sono le fasi dello sviluppo della società secondo Spencer?
9. Che ruolo gioca l'inconscio in Hartmann? 10. Qual è l'originalità degli insegnamenti di Nietzsche?
Hartman E. Filosofia dell'inconscio: In 2 volumi - M., 1875.
Hegel G. Enciclopedia delle scienze filosofiche: In 3 volumi - M., 1975-1977.
Kont O. Un corso di filosofia positiva: In 2 volumi - San Pietroburgo, 1899-1900. - T. 1.
Nietzsche F. Opere raccolte: - M, 1990. - Libro. 12.
Spencer g. Opere: In 7 Vol. - San Pietroburgo, 1898. - Vol. 1.
Feuerbach L. Opere filosofiche selezionate: In 2 volumi - M., 1955.
Fichte I. Chiaro come il sole, un messaggio al grande pubblico sulla vera essenza dell'ultima filosofia. - M., 1937.
Lettore di storia della filosofia: In 2 ore / Ed. ed. LA. Mikeshin. - M., 1994.
bombardamento F. Opere: In 2 voll. - M., 1987. - T. 1.
Schopenhauer A. Opere raccolte: In 5 voll.- M., 1992. - Vol. 1.
Hartman Edward (v. Hartmann) - il più popolare dei filosofi moderni della direzione metafisica, genere. a Berlino nel 1842. Il figlio di un generale prussiano, G., al termine del corso in ginnasio, entrò nel servizio militare. A causa della mancanza di vocazione per lei, oltre che di una malattia (sofferenze nervose del ginocchio), si ritirò presto e vive come privato a Berlino. Dopo studi infruttuosi di narrativa (dramma senza successo), si è concentrato sullo studio della filosofia e delle scienze necessarie per essa. Dopo aver conseguito un dottorato, pubblicò nel 1869 la sua opera principale: "Philosophie des Unbewussten", che gli portò subito fama, resistette a molte edizioni. Il punto di partenza per la filosofia dell'inconscio è la visione di Schopenhauer della volontà come la vera essenza di tutto l'essere e la base metafisica dell'intero universo. Schopenhauer, che nel titolo della sua opera principale univa la volontà all'idea (Welt als Wille und Vorstellung), di fatto un'essenza indipendente e originaria, considerava solo la volontà (l'elemento reale-pratico dell'essere), mentre l'idea (l'elemento intellettuale) riconosceva solo un prodotto subordinato e secondario della volontà. , intendendolo, da un lato, idealisticamente (nel senso di Kant), come un fenomeno soggettivo dovuto a forme a priori dello spazio, del tempo e della causalità, e dall'altro, materialisticamente, come dovuto alle funzioni fisiologiche dell'organismo o come "fenomeno cerebrale" (Gehirnphänomen). Contro un tale «primato della volontà», G. addita con forza il significato altrettanto primario della rappresentazione. “In ogni desiderio”, dice, “c'è un desiderio: l'effettivo passaggio di un certo stato presente in Altro. Lo stato reale è dato ogni volta, sia che si tratti di pace giusta; ma in questo solo stato presente, la volizione non potrebbe mai essere contenuta, se non ci fosse almeno la possibilità ideale di qualcos'altro. Anche un tale desiderio, che tende a continuare lo stato presente, è possibile solo attraverso la rappresentazione della cessazione di questo stato, quindi attraverso la doppia negazione. Non c'è dubbio, quindi, che due condizioni sono prima di tutto necessarie per la volizione, di cui una è lo stato presente come punto di partenza; l'altro, come meta del desiderio, non può essere lo stato presente, ma c'è un futuro la cui presenza è desiderata. Ma poiché questo stato futuro, in quanto tale, non può veramente essere nel presente atto di volere, ma intanto deve essere in qualche modo in esso, perché senza questo la volizione stessa è impossibile, quindi deve necessariamente essere contenuta in essa Perfetto, cioè come prestazione. Ma esattamente allo stesso modo, lo stato presente può diventare il punto di partenza della volizione solo nella misura in cui entra nella rappresentazione (distinto dal futuro). Così nessuna volontà senza immaginazione, come già dice Aristotele: "όρεκτικόν δε ούκ άνευ φαντασίας". In realtà c'è solo che rappresenta la volontà. Ma esiste come principio universale o metafisico entità? Volontà e rappresentazione si danno direttamente solo come fenomeni coscienza individuale degli esseri individuali, diversamente condizionati dalla loro organizzazione e dagli influssi dell'ambiente esterno. Tuttavia, nel campo dell'esperienza scientifica, possiamo trovare dati che suggeriscono un'esistenza indipendente e primaria del principio spirituale. Se ci sono nel nostro mondo tali fenomeni che, essendo del tutto inesplicabili da sole cause materiali o meccaniche, sono possibili solo come azioni del principio spirituale, cioè la volontà rappresentativa, e se, d'altra parte, è certo che nessun volontà e rappresentazione cosciente individuale (cioè la volontà e la rappresentazione dei singoli individui), allora è necessario riconoscere questi fenomeni come azioni di qualche universale, al di fuori della coscienza individuale della volontà rappresentante, che G. chiama perciò inconscio(das Unbewusste) (percependo, tuttavia, l'insoddisfazione di una tale designazione puramente negativa o difettosa (che può essere ugualmente applicata a una pietra o a un pezzo di legno, nonché all'inizio assoluto del mondo), G .nelle successive edizioni del suo libro ne consente la sostituzione a termine superconscio(da Ueberbewusste)). Infatti, ordinando (nella prima parte del suo libro) varie sfere di esperienza, sia interne che esterne, G. trova in esse i principali gruppi di fenomeni che possono essere spiegati solo dall'azione di un principio spirituale metafisico; sulla base di dati fattuali indubbi, attraverso il metodo induttivo della storia naturale, cerca di provare la realtà di questo soggetto primario di volontà e rappresentazione inconscio o superconscio. G. esprime i risultati della sua ricerca empirica nelle seguenti proposizioni: 1) l'"inconscio" forma e conserva corpo, corregge i suoi danni interni ed esterni, dirige intenzionalmente i suoi movimenti e ne condiziona l'uso alla volontà cosciente; 2) "inconscio" cede istinto ogni creatura ha bisogno di ciò di cui ha bisogno per la sua conservazione e per il quale il suo pensiero cosciente non è sufficiente, ad esempio, per una persona - istinti per comprendere la percezione sensoriale, per la formazione di un linguaggio e di una società, e molti altri. altri; 3) "inconscio" salva parto mediante il desiderio sessuale e l'amore materno, li nobilita mediante la scelta nell'amore sessuale e conduce costantemente il genere umano nella storia verso la meta della sua possibile perfezione; 4) l '"inconscio" controlla spesso le azioni umane attraverso sentimenti e premonizioni dove il pensiero pienamente cosciente non poteva aiutarli; 5) l '"inconscio" con le sue suggestioni nel piccolo, così come nel grande, promuove il processo cosciente del pensiero e porta una persona a misticismo ad una premonizione di unità soprannaturali superiori; 6) esso, infine, dona alle persone un senso di bellezza e creatività artistica. In tutte queste azioni, lo stesso "inconscio" è caratterizzato, secondo G., dalle seguenti proprietà: indolore, instancabilità, natura insensibile del suo pensiero, atemporalità, infallibilità, immutabilità e unità interna inseparabile. Riducendo, sulla scia dei fisici dinamici, le sostanze a forze atomiche (o centri di forze), G. riduce poi queste forze a manifestazioni di un principio metafisico spirituale. Ciò che per un altro, dall'esterno, è potere, allora in sé, dentro, c'è volontà, e se volontà, allora anche rappresentazione. La forza atomica di attrazione e repulsione non è solo una semplice spinta o attrazione, ma una tensione completamente definita (le forze di attrazione e repulsione sono soggette a leggi rigorosamente definite), cioè contiene una certa direzione definita e consiste Perfetto(altrimenti non sarebbe contento aspirazioni), cioè come vista. Quindi, gli atomi - le fondamenta dell'intero mondo reale - sono solo atti elementari della volontà, una certa rappresentazione, certo, gli atti di quella volontà (e rappresentazione) metafisica, che G. chiama "inconscio". Poiché, quindi, sia il polo fisico che quello mentale dell'esistenza fenomenica - sia la materia che la coscienza particolare condizionata dalla materia organica - risultano essere solo forme del fenomeno dell'"inconscio", e poiché esso è incondizionatamente non spaziale, perché lo spazio stesso dovrebbe essere (rappresentazione - ideale, volontà - reale), allora questo "inconscio" è un essere individuale onnicomprensivo, che è tutto ciò che esiste;è l'assoluto indivisibile, e tutti i molteplici fenomeni del mondo reale sono solo azioni e aggregati di azioni dell'essere tutto unito. La giustificazione induttiva di questa teoria metafisica costituisce la parte più interessante e preziosa della "filosofia dell'inconscio". Il resto è dedicato al ragionamento scolastico e alle fantasie gnostiche sull'inizio e la fine del mondo e sulla natura del processo mondiale, nonché all'esposizione e alle prove del pessimismo di Hartmann. Avendo prima riconosciuto l'inseparabile combinazione di volontà e idea (o idea) in un unico soggetto superconscio, che possiede tutti gli attributi del Divino, G. quindi non solo separa la volontà e l'idea, ma le personifica anche in questo isolamento, come maschio e principi femminili (che è conveniente solo in lingua tedesca: der Wille, die Idea, die Vorstellung). La volontà in sé ha solo il potere della realtà, ma è assolutamente cieca e irragionevole, mentre l'idea, sebbene brillante e ragionevole, è assolutamente impotente, priva di qualsiasi attività. All'inizio entrambi questi principi erano in uno stato di pura potenza (o non esistenza), ma poi la volontà inesistente ha voluto volere assolutamente accidentalmente e senza senso e così è passata dalla potenza all'atto, trascinando l'idea passiva nella stesso luogo. L'essere reale, che, secondo G., è postulato esclusivamente dalla volontà - l'inizio di una irragionevole, - quindi, si distingue esso stesso per il carattere essenziale dell'irragionevolezza o dell'insensatezza; è ciò che non dovrebbe essere. In pratica, questa irragionevolezza dell'essere si esprime come disastro e sofferenza, a cui tutto ciò che esiste è inevitabilmente soggetto. Se l'origine originaria dell'esistenza stessa - il passaggio senza causa della volontà cieca dalla potenza all'atto - è un fatto irrazionale, un accidente assoluto (der Urzufall), allora la ragionevolezza, o finalità, del processo mondiale riconosciuto da G. ha solo un significato condizionale e negativo; consiste nella preparazione graduale alla distruzione di ciò che è stato creato dall'atto irragionevole primario della volontà. Un'idea razionale, negativamente correlata all'effettiva esistenza del mondo come prodotto di una volontà insensata, non può, tuttavia, abolirla direttamente e immediatamente, essendo essenzialmente impotente e passiva: quindi, indirettamente raggiunge il suo scopo. Controllando le forze cieche della volontà nel processo mondiale, crea le condizioni per l'apparizione degli esseri organici in possesso coscienza. Attraverso la formazione della coscienza, l'idea del mondo o mente del mondo (in tedesco e mente - femminile: die Vernunft) è liberata dal dominio della volontà cieca, e tutto ciò che esiste ha l'opportunità, dalla negazione consapevole del desiderio vitale, di ritornare nuovamente a uno stato di pura potenza, o non esistenza, che costituisce quest'ultimo obiettivo del processo globale. Ma prima di raggiungere questo obiettivo più alto, la coscienza mondiale, concentrata nell'umanità e in continuo progresso in essa, deve passare attraverso tre stadi di illusione. All'inizio, l'umanità immagina che la beatitudine sia realizzabile per una persona nelle condizioni dell'esistenza naturale terrena; nel secondo, cerca la beatitudine (anche personale) in un presunto aldilà; sul terzo, avendo abbandonato l'idea della felicità personale come obiettivo supremo, si adopera per il benessere collettivo generale attraverso il progresso scientifico e socio-politico. Delusa da quest'ultima illusione, la parte più cosciente dell'umanità, concentrando in sé la maggior parte della volontà mondiale (?!), decide di suicidarsi e, attraverso questo, di distruggere il mondo intero. Metodi di comunicazione migliorati, osserva G. con incredibile ingenuità, daranno all'umanità illuminata l'opportunità di accettare ed eseguire immediatamente questa decisione suicida. Scritta da un giovane di 26 anni, la "filosofia dell'inconscio", ricca nella sua prima parte di indicazioni corrette e importanti, accostamenti spiritosi e generalizzazioni ampie, ha mostrato grandi promesse. Sfortunatamente, lo sviluppo filosofico dell'autore si fermò ai primi passi. Nonostante le evidenti contraddizioni e incongruenze del suo sistema metafisico, non cercò di correggerlo, e nei suoi numerosi ulteriori scritti sviluppò solo alcune domande particolari o adattò vari ambiti della vita e della conoscenza al suo punto di vista. Le più importanti di queste opere sono: "Kritische Grundlegung des transscendentalen Realismus", "Ueber die dialektische Methode Neukantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus", "Das Unbewusste vom Standpunkt der Physiologie und Descendenztheorie", "Wahrheit und Irrthum im Darwinismus", "Phänomenologie dessittselichens " , "Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus", "Die Selbstzersetzung des Christenthums und die Religion der Zukunft", "Die Krisis des Christenthums in der modernen Theologie", "Das religiöse Bewusstseyn der Menschheit", "Die Religion des Geistes", " Die Estetik". G. scrisse anche di spiritualismo, questione ebraica, politica e educazione tedesca. La filosofia G. ha prodotto una letteratura abbastanza ampia. La sua opera principale è stata tradotta in molte lingue straniere. In russo c'è una traduzione in qualche modo abbreviata di A. A. Kozlov, dal titolo: "The Essence of the World Process". Tra gli autori di singole opere su G. - a favore e contro di lui - si possono citare: Weis, Bahnsen, Stiebeling, J. C. Fischer, A. Taubert (prima moglie di G.), Knauer, Volkelt, Rehmke, Ebbinghaus, Hansemann, Venetianer, Heman, Sonntag, Huber, Ebrard, Bonatelli, Carneri, O. Schmid, Plümacher, Braig, Alfr. Weber, Kober, Schüz, Jacobowski, libro. DN Tsertelev (pessimismo moderno in Germania). Un elenco cronologico della letteratura su G. è allegato all'opera Plümacher "a" Der Kampf ums Unbewusste ". Vedi anche nella storia della nuova filosofia di Iberweg-Heinze (traduzione russa di J. Kolubovsky). Vlad. Solovyov. Dizionario Enciclopedico F.A. Brockhaus e I.A. Efron. - San Pietroburgo: Brockhaus-Efron.
1890-1907
.
Guarda cos'è "Eduard Hartmann" in altri dizionari:
Eduard Hartmann (1842 1906) tedesco. filosofo, creatore della “filosofia dell'inconscio”, sorta in opposizione al dominante il mar. pavimento. 19esimo secolo positivismo. G. considerava i suoi predecessori Platone, Schelling, Hegel e Schopenhauer. La sua… … Enciclopedia degli studi culturali
- (1842 1906) Filosofo tedesco, sostenitore del panpsichismo. La base dell'esistenza considerata il principio spirituale inconscio assoluto della volontà mondiale (Filosofia dell'inconscio). In etica, seguendo A. Schopenhauer, sviluppò il concetto di pessimismo... Grande dizionario enciclopedico
- (1842 1906), filosofo tedesco, sostenitore del panpsichismo. Considerava il principio spirituale inconscio assoluto, la volontà del mondo, come base dell'esistenza ("Filosofia dell'inconscio"). In etica, seguendo A. Schopenhauer, ha sviluppato il concetto di pessimismo. * * * HARTMAN… dizionario enciclopedico
Eduard Hartmann (23 febbraio 1842, Berlino, 5 giugno 1906, Groslichterfelde), filosofo idealista tedesco. Le fonti della filosofia di G. erano il volontarismo di A. Schopenhauer e la "filosofia dell'identità" di Schelling. Opere G. "Filosofia dell'inconscio" (1869, 12 ... ... Grande enciclopedia sovietica
- (Hartmann), (23 febbraio 1842 - 5 giugno 1906) - Tedesco. filosofo idealista. Il volontarismo di Schopenhauer e la filosofia dell'identità di Schelling furono le fonti ideologiche della filosofia di G.. La sua filosofia dell'inconscio (Philosophie des Unbewussten, 1869; 12a ed. 1923) ... ... Enciclopedia filosofica
Hartman Edward- a lui noto. filosofo pessimista. All'età di 26 anni, ha guadagnato fama mondiale grazie al suo lavoro La filosofia dell'inconscio ... Dizionario enciclopedico teologico ortodosso completo Storia della filosofia: Enciclopedia
Eduard (1842-1906), filosofo tedesco, fautore del panpsichismo. Considerava il principio spirituale assolutamente inconscio della volontà del mondo come base dell'esistenza (Filosofia dell'inconscio, 1869). In etica, seguendo A. Schopenhauer, sviluppò il concetto di pessimismo... Enciclopedia moderna
Prima di tutto, parliamo delle opinioni di Hartmann sull'inconscio. Secondo Hartmann, l'inconscio è di tre tipi: 1.
Inconscio fisiologico. 2.
Relativo inconscio. 3.
Inconscio assoluto.
Il primo include tracce di memoria, che, secondo Hartmann, rappresentano cambiamenti molecolari nel cervello che facilitano la ricomparsa di rappresentazioni note.
L'inconscio fisiologico non è ancora lo psichico.
Questa è solo una predisposizione molecolare, quindi la visione di Hartmann della memoria è puramente materialistica.
Ma l'inconscio relativo è già psichico. Ad esso corrispondono fenomeni nei centri gangliari, poiché le funzioni del grande cervello corrispondono ad atti mentali coscienti.
È necessario distinguere tra la coscienza centrale, che è la mia coscienza, dalla coscienza degli ordini inferiori, le coscienze secondarie. Per queste coscienze l'inconscio relativo è già cosciente, mentre per la coscienza centrale è inconscio.
L'inconscio assoluto non ha più un correlato fisiologico. È un inizio più metafisico che psicologico. Questo è l'inconscio di Esso, che già in Karus non ha dubbi, esitazioni, fatiche di graduale esercizio e studio, e agisce sempre con fiducia, con saggezza e grazia, disinvoltura e immutabile immediatezza. Determina opportunamente la struttura del corpo al momento della fecondazione e si manifesta nelle sue malattie, sotto forma di forza curativa della natura.
Questo inconscio è elevato da Hartmann all'inizio principale del processo mondiale, rappresenta la sintesi della volontà di Schopenhauer e dell'idea di sviluppo di Hegel. L'inconscio metafisico assoluto non include le sensazioni inconsce. Si può essere pienamente d'accordo con Fechner e Vorplage sul fatto che la sensazione può essere solo cosciente, che quando lo stimolo scende al di sotto di una certa soglia, non c'è affatto sensazione della coscienza centrale, e che lo stesso avviene per le sensazioni delle coscienze secondarie24, cioè. la famosa formula di Weber-Fechner, che collega la sensazione con l'irritazione, è applicabile anche all'inconscio relativo, ma solo per altri valori dei parametri. Dovrebbe essere lasciato solo il relativo inconscio. L'inconscio assoluto di Hartmann dovrebbe essere completamente scartato, poiché la questione della struttura dell'anima dovrebbe essere considerata indipendentemente dalle premesse metafisiche. L'inconscio assoluto può rimanere solo come un fondamento passivo della vita della coscienza, un serbatoio di memoria. Nel risolvere problemi psicologici, l'inconscio assoluto nel senso hartmanniano può solo fare del male.
Già prima di Hartmann, Fichte Jr. sosteneva che la coscienza fosse solo un effetto collaterale, qualcosa di puramente accessorio allo spirito, un segno, e non indipendente, essenziale. L'agente principale è l'inconscio.
Ma se si introduce l'inconscio relativo, fornendo alla coscienza centrale un intero esercito di coscienze secondarie subordinate, tutto ciò che Fichte attribuisce all'inconscio assoluto cadrà su questa coscienza secondaria. Solo la coscienza resta attiva, l'inconscio si riduce alla pura passività.
Non la coscienza, ma l'inconscio è un'appendice, mentre la coscienza è una sostanza, ma non un accidente, non solo una lanterna che illumina il contenuto dell'anima, ma una forza attiva. La volontà non è mai cieca, come desidera Schopenhauer; il desiderio si risveglia nella coscienza, nell'inconscio lo è.
12. Protezione dell'inconscio.
Va ben ricordato che l'inconscio relativo è psichico solo per le coscienze secondarie, e non per la coscienza centrale, e ciò che è cosciente per la coscienza centrale può o non può essere riconosciuto dalla coscienza secondaria.
Solo questo percorso, scelto da Hartmash, permette di porre fine alle obiezioni all'inconscio psichico. Se Wundt chiama l'attività mentale inconscia un concetto contraddittorio, poiché denota un'azione spirituale, ma non attiva, allora si può rispondere che qui non stiamo parlando dell'inconscio assoluto, ma solo del relativo, che questa attività è inconscia solo per il mio ego, ma è di per sé cosciente come quell'attività di cui sono consapevole che opera nella sua area più ristretta, proprio come la mia coscienza centrale opera in un'area più ampia.
La complessità di quei fenomeni per i quali l'inconscio è il principio esplicativo contrasta fortemente con la visione ristretta (es. Ziegler25), che riduce l'inconscio alle piccole percezioni di Leibniz26, che sono alla soglia della coscienza, ma, di fatto, non cadono mai al di sotto di essa .
Di solito la vecchia psicologia speculativa si oppone alla moderna psicologia sperimentale. La prima è una metafisica senza fondamento, la seconda è una scienza positiva. Indicano, attenendosi allo schema kantiano27. e il fatto che la psicologia si stia ora spostando dal secondo periodo - metafisico, al terzo - positivo, che attualmente deve già operare solo con elementi forniti da osservazioni ed esperienze scientificamente stabilite. Ma la storia non solo della psicologia, ma anche di altre scienze ad essa collegate, suggerisce che l'insegnamento di O. Comte riguarda tre stadi di sviluppo; teologico, metafisico e positivo: una grande illusione. In queste scienze, i tentativi di espellere completamente gli elementi metafisici sono sempre rimasti vani e. La loro evoluzione non procedeva in modo tale da salire da un livello della gerarchia comteana al più alto, ma si allungava in modo che una parte risultasse essere al livello più alto, mentre le altre dovevano necessariamente rimanere nella sfera della pensiero metafisico più vago e più problematico.
Questa visione è supportata anche dall'economia politica, che negli altri suoi campi porta sicuramente alla matematizzazione, dove, insieme alla formula di Paretto e alle deduzioni matematiche da essa, ci sono argomenti su valore, prezzo, ecc., condannati a uno stato metafisico.
Lo stesso vale per la psicologia, in cui gli elementi metafisici vivranno sempre fianco a fianco con la matematica psicofisica. La psicologia, timorosa del misticismo e attaccata alla fisiologia, è caratterizzata da un'estrema povertà di spiegazioni, che ruotano tutte attorno alle leggi dell'associazione.
Non appena la psicologia vuole diventare esplicativa, non solo descrivendo e classificando i fenomeni mentali, ma anche scomponendoli nei loro elementi semplici costitutivi, diventa immediatamente necessario introdurre nel loro numero elementi metafisici o mistici, sfuggenti alla diretta osservazione scientifica, portanti un ipotetico carattere e tutto questo sconvolge i positivisti... La psicologia di Herbert ha un carattere metafisico molto chiaramente espresso ed è strettamente connessa con il suo sistema metafisico. Si può argomentare sulla forza dei suoi principi, ma è indiscutibile che ha un potere esplicativo, non solo descrive, ma spiega, inoltre matematizza i suoi risultati.
Poiché abbiamo a che fare con un riflesso, siamo ancora nel regno della fisiologia, ma gli atti psichici automatici appartengono già alla psicologia.
Questi atti ci portano all'inconscio psichico già quando spieghiamo i fenomeni più semplici, come suonare il pianoforte o cucire, e, allo stesso tempo, pensare a soggetti completamente diversi, ci portano al riconoscimento dell'attività mentale che si svolge al di fuori della coscienza, attività mentale che è già a suo modo definizione, può servire come oggetto di osservazione diretta, ma è destinata a rimanere sempre un elemento ipotetico. Moleno chiama coraggiosamente questo elemento mistico. Infatti, l'inconscio non si trova nello spazio, non può servire come oggetto di esperienza interiore per nessuno, esiste in una sfera speciale dell'essere, non separato da noi ed esercita il suo effetto su di noi. La paura degli psicologi positivisti è abbastanza comprensibile: il vecchio demonismo dovrebbe rivivere nell'inconscio, il mondo mistico dovrebbe risorgere non appena superiamo la timidezza e desideriamo prendere con l'aiuto dell'inconscio le fortezze apparentemente inespugnabili. L'inconscio può servire come principio esplicativo solo a condizione che le funzioni mentali inconsce siano del tutto analoghe a quelle consce. L'inconscio associa rappresentazioni come la coscienza. Sente e prega per sentire ciò che sente la coscienza. Ha il suo serbatoio di memoria e da lì trae i suoi ricordi e può anche ricordare ciò che la coscienza ricorda. Pertanto, le loro esperienze si intrecciano.
Il problema cardinale degli spiritualisti è il problema della sede dell'anima. Ecco la radice della divergenza tra metafisica aristotelico-scolastica e metafisica cartesiana. La prima colloca l'anima in tutto il corpo, la seconda indica il suo posto; la macchina corporea dell'anima è controllata da una specie di manico o forchetta.
Parole chiave
E. VON HARTMANN / F. SCHELLING / DIO / RELIGIONE DEL FUTURO/ CRISTIANESIMO / INCONSCIO/ PESSIMISMO / E. VON HARTMANN / F. SCHELLING / DIO / RELIGIONE DEL FUTURO / CRISTIANESIMO / INCONSCIO / PESSIMISMOannotazione articolo scientifico su filosofia, etica, studi religiosi, autore di lavori scientifici - Zolotukhin Vsevolod Valerievich
L'articolo è dedicato alla considerazione della filosofia della religione di Eduard von Hartmann. L'autore spiega la sua critica alla teologia liberale: secondo E. von Hartmann, il cristianesimo è sull'orlo della morte. Tuttavia, le persone hanno ancora un bisogno religioso. Da qui la legittimità e la necessità di parlarne religioni del futuro. L'articolo mostra che, secondo l'opinione di E. von Hartmann, l'unica visione del mondo in grado di soddisfare il bisogno religioso di una persona in futuro è il panteismo o "monismo concreto". Secondo questa impostazione filosofica e teologica, l'assoluto è inconscio e la vera base trascendentale dell'individualità umana è identica all'Assoluto inconscio se stesso. L'obiettivo della vita umana è la salvezza, intesa come dissoluzione postuma in profondità ontologiche. inconscio sé (assoluto). essenza religioni del futuro E. von Hartmann vede nella sintesi delle tradizioni spirituali orientali (indiane) e occidentali. Questa sintesi, secondo il filosofo, dovrebbe essere promossa dall'idealismo speculativo tedesco. Sulla base del materiale presentato, l'autore conclude che gli insegnamenti di E. von Hartmann sono una forma speciale di misticismo che evita l'acosmismo e riconosce fondamentalmente e incondizionatamente l'Assoluto inconscio. Una serie di caratteristiche, un contesto tematico e problematico, un metodo speculativo, una grande attenzione ai temi della teologia filosofica, consentono di inserire le costruzioni filosofiche di E. von Hartmann nell'ambito della tradizione speculativo-metafisica tedesca dell'Ottocento . L'autore mostra brevemente come le idee di E. von Hartmann siano in sintonia con la tarda filosofia di F. Schelling. Si conclude che gli insegnamenti di E. von Hartmann circa religioni del futuroè estremamente importante per la storia della filosofia, poiché può essere considerato l'unico progetto religioso costruito sulla base dell'idealismo tedesco in generale e del pensiero di Schelling in particolare.
Argomenti correlati articoli scientifici su filosofia, etica, studi religiosi, autore di lavori scientifici - Zolotukhin Vsevolod Valerievich
-
Eduard von Hartmann: schellingiano sconosciuto
-
Il soggetto senza predicato, o la teologia dell'inconscio in Fichte e Schelling
-
Due problemi principali e due fasi dell'idealismo speculativo tedesco
2015 / Vsevolod Zolotukhin -
L'idealismo tedesco come base teorica per la scienza della religione di Friedrich Max Müller
-
Il concetto di rivelazione della rivelazione di G.W.F. Hegel: verso una dichiarazione del problema
2014 / Boyko Pavel Evgenievich, Von Pentz Diana Yurievna -
Definizioni del mistico: la prima esperienza di esposizione
2017 / V. K. Shokhin -
La filosofia della religione di Fichte e il Vangelo di Giovanni
2019 / Sudakov Andrey Konstantinovich -
La mente universale, o la nascita dell'idealismo speculativo di Schelling
2017 / Vsevolod Zolotukhin -
In polemica con Schelling: Filosofia della fede di KA Eshenmaier
2016 / Vsevolod Zolotukhin -
Sulla questione dell'idea di base dell'idealismo speculativo tedesco
2014 / Vsevolod Zolotukhin
Eduard von Hartmann: religione post-cristiana e idealismo tedesco
Questo articolo è dedicato alla considerazione della filosofia della religione di Eduard von Hartmann. L'autore esamina il suo critico della teologia liberale. Ev Hartmann pensa che la religione cristiana stia morendo. L'umanità allo stesso tempo ha una necessità di religione. Quindi il problema della religione post-cristiana viene posto come legittimo e importante argomento di discussione. L'articolo mostra che, secondo l'opinione di E.v. Hartmann, l'unica prospettiva mondiale in grado di soddisfare l'anelito spirituale umano in futuro è il monismo concreto. Insegna che l'Assoluto è inconscio. Il vero fondamento trascendente dell'uomo è il Sé inconscio (Assoluto). Lo scopo finale della vita consiste nella salvezza, cioè la dissoluzione con la morte fisica nella profondità ontologica del Sé. La religione del futuro è vista da E.v.Hartmann nella sintesi delle correnti spirituali orientali (indiane) e occidentali. Secondo il filosofo, l'idealismo speculativo tedesco deve favorire questa sintesi. La teoria di E.v.Hartmann è una forma originale del misticismo che evita l'acosmismo e riconosce incondizionatamente l'incoscienza dell'Assoluto. L'analisi storica permette di includere la filosofia di E.v. Hartmann nella tradizione metafisica tedesca del XIX secolo. L'autore dimostra brevemente la notevole vicinanza delle idee di E. v.Hartmann alla successiva filosofia di F.Schelling. Conclude che la dottrina della futura religione di E.v.Hartmann è molto importante per la storia della filosofia perché può essere considerata l'unico progetto religioso costruito sulla base dell'idealismo tedesco in comune e del pensiero di Schelling in particolare.
Il testo del lavoro scientifico sul tema "Eduard von Hartmann: religione post-cristiana e idealismo tedesco"
^ TrZL RUDN Journal of Philosophy 2017 vol. 21 n. 1 7-16
Bollettino dell'Università RUDN. Serie: FILOSOFIA http://journals.rudn.ru/philosophy
EDUARD VON HARTMANN: RELIGIONE POSTCRISTIANA E IDEALISMO TEDESCO
VV Zolotukhin
Istituto di Filosofia e Scienze Socio-Politiche Università Federale Meridionale st. Bolshaya Sadovaya, 105, Rostov sul Don, Russia, 344006
L'articolo è dedicato alla considerazione della filosofia della religione di Eduard von Hartmann. L'autore spiega la sua critica alla teologia liberale: secondo E. von Hartmann, il cristianesimo è sull'orlo della morte. Tuttavia, le persone hanno ancora un bisogno religioso. Si sostanzia così la legittimità e la necessità di parlare della religione del futuro.
L'articolo mostra che, secondo E. von Hartmann, l'unica visione del mondo in grado di soddisfare il bisogno religioso di una persona in futuro è il panteismo o "monismo concreto". Secondo questo atteggiamento filosofico e teologico, l'assoluto è inconscio, e la vera base trascendentale dell'individualità umana è il sé inconscio identico all'Assoluto. L'obiettivo della vita umana è la salvezza, intesa come dissoluzione postuma nelle profondità ontologiche dell'inconscio (Assoluto). E. von Hartmann vede l'essenza della religione del futuro nella sintesi delle tradizioni spirituali orientali (indiane) e occidentali. Questa sintesi, secondo il filosofo, dovrebbe essere promossa dall'idealismo speculativo tedesco.
Sulla base del materiale presentato, l'autore conclude che gli insegnamenti di E. von Hartmann sono una forma speciale di misticismo che evita l'acosmismo e riconosce fondamentalmente e incondizionatamente l'Assoluto come inconscio. Una serie di caratteristiche - contesto tematico e problematico, metodo speculativo, grande attenzione ai temi della teologia filosofica - consentono di inserire le costruzioni filosofiche di E. von Hartmann nell'ambito della tradizione speculativo-metafisica tedesca dell'Ottocento.
L'autore mostra brevemente come le idee di E. von Hartmann siano in sintonia con la tarda filosofia di F. Schelling. Si conclude che l'insegnamento di E. von Hartmann sulla religione del futuro è estremamente importante per la storia della filosofia, poiché può essere considerato l'unico progetto religioso costruito sulla base dell'idealismo tedesco in generale e del pensiero di Schelling in particolare .
Parole chiave: E. von Hartmann, F. Schelling, Dio, religione del futuro, cristianesimo, inconscio, pessimismo
Seconda metà del 19° secolo rappresenta un periodo molto particolare nella storia della filosofia tedesca. La prima metà del secolo è segnata dalla creazione di sistemi idealistici monumentali da parte di I.G. Fichte, F.W.J. Schelling e G.W.F. Hegel. Alla fine degli anni '20. un'altra generazione di idealisti venne alla ribalta - Imm. G. Fichte (figlio), H.G. Weiss e altri. A partire dalle costruzioni di Schelling e, in una certa misura, di Hegel, hanno cercato di sostanziare speculativamente la visione teistica del mondo.
Parallelamente a ciò, nel 19° secolo, e in modo particolarmente evidente nel suo mezzo, ebbero luogo numerosi altri processi interconnessi. Da un lato, in rapido sviluppo
scienze naturali, che hanno comportato la crescita del loro prestigio e l'influenza sulla sfera intellettuale in generale. Di conseguenza, il metodo empirico ha guadagnato sempre più popolarità e una massa critica di sfiducia nei confronti delle costruzioni speculative è cresciuta nella comunità scientifica. Divenne sempre più difficile erigere "edifici" filosofici speculativi. Lo storico della filosofia tedesco A. Schneider sottolinea: “... durante il secondo terzo dell'Ottocento. alcuni rappresentanti dell'idealismo si sentono sempre più obbligati, se non completamente, ad abbandonare le loro aspirazioni sistematiche, quindi in qualche modo a riconciliarle con le esigenze delle scienze positive, oppure a proteggere le loro aspirazioni e progetti chiave dalle pretese di queste scienze.
D'altra parte, la secolarizzazione della società europea, e in particolare tedesca, procedeva a ritmi sostenuti. Fu connesso, tra l'altro, alla trasformazione della teologia protestante: iniziò ad avvicinarsi alla filosofia non confessionale, che si rifletteva chiaramente nell'opera di F. Schleiermacher. Quindi, nella sua lettura ripetuta negli anni 1810-20. Nelle sue lezioni sulla dialettica, Schleiermacher, seguendo Kant, afferma: “...l'idea del mondo è il limite del nostro pensiero. Il terreno trascendente è al di là del pensiero." Il grande teologo dice che ogni ontologia che si costruisce è solo simbolica, perché «l'esistenza del mondo in sé... non ci è data». Questa sua affermazione, così come l'idea che Dio non può essere concepito senza il mondo, e il mondo senza Dio, testimonia la consonanza senza precedenti della teologia protestante con la tradizione metafisica europea.
La crisi dell'ortodossia luterana è completata da studi storico-critici nel campo degli studi biblici, che danno alla teologia un positivo impulso scientifico.
Il punto di svolta qui è la Vita di Gesù di Strauss. I teologi si rivolgono allo studio delle fonti, all'analisi linguistica e storica dei testi sacri, pur rifiutando di attribuire un'importanza decisiva all'autorità della precedente tradizione teologica e alla sua esegesi.
Era in questo momento, negli anni '60. XIX secolo, sorge la stella di Eduard von Hartmann (1842-1906). Era figlio di un generale prussiano e, a differenza degli idealisti tedeschi, era un pensatore fuori dall'università. Quasi dimenticato oggi, von Hartmann brillò alla fine del secolo prima dell'ultimo e la sua opera principale, La filosofia dell'inconscio (1868), aveva attraversato 11 edizioni al momento della sua morte.
Il filosofo è conosciuto principalmente come un araldo del pessimismo della visione del mondo. Ha cercato di dare a quest'ultimo una solida giustificazione speculativa. Un contemporaneo del filosofo R. Falkenberg caratterizza il suo insegnamento come segue: “Eduard von Hartmann ... cerca nella sua filosofia di sintetizzare Schopenhauer e Hegel (1), cercando di combinare il pessimismo del primo con l'evoluzionismo del secondo, e mentre il primo intende l'essenza del mondo come una volontà irragionevole, e il secondo considera questa essenza come un'idea logica - lo stesso Hartmann, sull'esempio del compianto Schelling, prende volontà e rappresentazione come attributi uguali del suo assoluto - l'"Inconscio ".
Sottolineeremo brevemente l'interazione tra Schelling e von Hartmann, ma ora considereremo le idee principali della metafisica di Hartmann, su cui si basa la sua filosofia della religione.
L'inconscio risulta essere l'unica e unica sostanza totalizzante di E. von Hartmann. Il filosofo lo descrive in modo apofatico, come il Tao cinese: “non è né grande né piccolo; Né qui né là; né in un'immagine, né in un punto; non da nessuna parte, non da nessuna parte." L'inconscio genera sia ciò che potremmo chiamare la realtà materiale (ad esempio, lo spazio) sia il mondo spirituale (coscienza umana). Nell'uomo, per la prima volta, l'Assoluto inconscio diventa cosciente di se stesso.
La volontà (principio attivo, appassionato, guida dell'essere) si sforza di raggiungere la beatitudine. Eduard von Hartmann, tuttavia, fa grandi sforzi per dimostrare che la beatitudine nel mondo è irraggiungibile, è stata e rimarrà un'arena di dolori e disgrazie. L'essere è decisamente teleologico, ma il suo fine ultimo non può essere né la beatitudine positiva, né la libertà, né il trionfo della moralità, né il fatto stesso dell'emergere della coscienza.
L'obiettivo finale, secondo von Hartmann, è una situazione in cui una rappresentazione logica, mentale, distaccata dalla volontà, ferma l'impulso cieco e senza scopo della volontà. In altre parole, l'umanità razionale, liberata la sua coscienza dal dominio della volontà, deve estinguere il desiderio di vivere e, in qualche modo sconosciuto, arrivare alla sua stessa autodistruzione graduale, riportando così la volontà alla sua originaria stato inconscio. Questo sarà il compimento degli "obiettivi dell'inconscio".
Passiamo ora alla filosofia della religione. Nel 1874 fu pubblicato il libro di E. von Hartmann "The Self-Decomposition of Christianity or the Religion of the Future". In essa il giovane filosofo esprime le sue idee chiave riguardo al problema che ci interessa.
L'argomento dell'analisi in The Self-Decomposition of Christianity... è il protestantesimo liberale tedesco. Allo stesso tempo, il filosofo fu influenzato da L. Feuerbach e D.F. Strauss, con quest'ultimo che influenza la metodologia. E. von Hartmann giunge alla conclusione che il protestantesimo liberale è al di fuori della religione in generale e al di fuori del cristianesimo in particolare. Il filosofo sottolinea che la critica biblica, mettendo in discussione l'autorità della tradizione cristiana, porta all'erosione dell'autorità assoluta di Cristo. Il rifiuto della fede nella rivelazione divina data nella vera Scrittura significa una vera rottura con la tradizione cristiana. I teologi liberali non credono alla divinità di Gesù Cristo, e ancor di più non lo percepiscono come l'unto di Dio: per loro è proprio il fondatore della religione cristiana. E. von Hartmann chiede: se i teologi non considerano Cristo Dio e i suoi insegnamenti veri, allora che tipo di cristiani sono?
Il popolo, «non più cristiano in senso stretto», ma nello stesso tempo «ad eccezione delle grandi città, non è ancora diventato irreligioso», non è imbarazzato dall'allontanamento di fatto dei teologi liberali dal cristianesimo e, ascoltando soddisfano il loro sentimento di protesta contro l'autorità della tradizione.
La religione, secondo von Hartmann, è un'unità di idee metafisiche e un sentimento positivo che le rafforza, a cui si aggiunge un culto.
e un insieme di precetti morali giustificati in modo trascendentale. Metafisica e sentimento sono indissolubilmente legati tra loro e l'indebolimento di uno di questi fattori porta al degrado o all'estinzione della religione.
Per il popolo, la religione sostituisce ogni conoscenza filosofica e punta a qualcosa di più elevato, di non materiale. Nella religione, cerca la Verità con la lettera maiuscola. E dove cerca la verità il protestantesimo liberale? Von Hartmann risponde: nella storia della filosofia. Egli attinge alla storia della teologia solo nella misura in cui contiene un elemento speculativo-filosofico. Allo stesso tempo, i teologi liberali evitano la metafisica, uno degli elementi più importanti della religione.
Il filosofo afferma: sia il cattolicesimo che il protestantesimo stanno attualmente scivolando nella non religione laica (è ovvio che la laicità moderna ha almeno un secolo e mezzo di storia nell'Europa continentale). Il cristianesimo, decollato con Tommaso d'Aquino all'apice, ha poi compiuto un declino, tanto che "l'ordinata della curva cristiana ha finalmente raggiunto di nuovo lo zero, come era all'inizio, ma la posizione sull'ascissa è ora incomparabilmente diversa"
Poiché il cristianesimo sta morendo e il bisogno di religione tra le persone non scompare, allora con cosa può essere sostituito?
Ricordiamo che il mondo è una valle di sofferenza ed è impossibile migliorarla. L'uomo, invece, ha un sentimento di dipendenza da qualcosa di più alto (qui von Hartmann eredita chiaramente l'idea di Schleiermacher). L'uomo dipende assolutamente da Dio, e questa connessione con Dio non dovrebbe essergli oscurata dalla relativa dipendenza dal mondo finito.
Il filosofo si pone il compito di pensare il mondo in modo tale che, da un lato, sia assolutamente dipendente dall'Assoluto e, dall'altro, mantenga la sua realtà ontologica e non diventi un'illusione o un elemento della realtà divina. Riguardo a questo problema importantissimo, egli è il successore dell'idealismo tedesco. Fu in esso che ci furono controversie sullo status ontologico del mondo, le posizioni teistiche si opposero a quelle panteistiche e furono fatti tentativi per conciliare queste due opposte posizioni di visione del mondo. Vicino all'idealismo tedesco c'è il desiderio di Hartmann di creare un sistema metafisico integrale che spieghi tutti gli aspetti dell'esistenza umana e naturale.
Von Hartmann rifiuta sia l'atteggiamento panteistico, che considera l'Universo come l'Assoluto stesso, sia il dualismo platonico dello spirituale e del materiale, del demiurgo e dello hyule. Il primo, il primo stadio considerato dello sviluppo filosofico e teologico, lo chiama "monismo naturalistico": questa, secondo il pensatore, è l'antica religione egizia. Il monismo naturalistico non pone la domanda sul fondamento e sull'essenza del mondo, e se lo fa, allora lo spirituale è in qualche modo dissolto nel materiale (2).
La seconda segna la separazione della realtà spirituale da quella materiale, per cui lo Spirito diventa un principio ontologico autonomo, de-
miurgo del mondo materiale. Nonostante per una tale visione del mondo, la realtà assoluta sia solo la combinazione di questi due principi, qui un passo, seppur a metà, è già stato fatto verso il teismo. Lo spirito non è ancora assoluto, ma già domina la materia. Il dualismo conduce al teismo, mentre il monismo naturalistico conduce all'ateismo.
La critica del teismo costituisce una base metodologica peculiare per il rifiuto del cristianesimo. Nel teismo, secondo E. von Hartmann, la realtà del mondo è assicurata solo dalla perdita dello statuto assoluto di Dio. Non appena Dio ha creato il mondo “in sé e per sé esistente”, funzionalmente indipendente, materiale e sviluppandosi secondo le proprie leggi, si può sostenere che il mondo è una sostanza speciale, temporanea e creata. Ciò significa che non c'è unità sostanziale di Dio e del mondo. Lo stato assoluto di Dio si sposta in potenza: il mondo esiste secondo le leggi della natura. Naturalmente, queste leggi sono create da Dio, ma in un mondo sostanzialmente autonomo operano in modo relativamente indipendente dall'effettiva volontà di Dio. Quest'ultimo può manifestarsi nel mondo solo con l'aiuto di un miracolo. Solo un miracolo fornisce al teismo un legame religioso tra Dio e l'uomo, poiché significa il loro contatto diretto. Il teismo generalmente esiste ammettendo la possibilità di un miracolo. La sua popolarità nella storia mondiale è assicurata dal "realismo ingenuo" insito nella coscienza delle persone. Inoltre, se si postula la sostanzialità e l'indipendenza del mondo, allora la sua dipendenza da Dio può essere spiegata solo per mezzo della "guida divina soprannaturalmente miracolosa".
Il teismo non può dissuadere una persona dal fatto che dipende dal mondo, perché questo richiede un miracolo, che è noto per essere unico e raro. Inoltre, il teismo, che si oppone all'uomo ea Dio come Io e Te, non riesce a realizzare la loro reale unità.
Se si rifiuta la possibilità di un miracolo, il teismo si trasforma in deismo, perché. l'attualità di Dio si riduce solo all'atto originario della creazione. Il deismo, a sua volta, non soddisfa nemmeno la coscienza religiosa, perché rappresenta il mondo come un meccanismo lanciato da Dio, e Dio stesso non partecipa all'opera del meccanismo. Questo non si addice a una persona religiosa: ha bisogno di un Dio vivo, che agisce costantemente nel mondo. La tiepidezza del deismo è la chiave della sua instabilità: si evolve o di nuovo nel teismo o nell'ateismo materialista.
Il monismo astratto (incarnato, secondo E. von Hartmann, in Brahmanism and Buddhism), a differenza del teismo, fornisce lo status assoluto di Dio, ma ha un altro grave inconveniente. Il soggetto delle relazioni religiose - l'uomo - è qui privato di realtà e si trasforma in illusione. L'unità dell'uomo e di Dio in questo caso si realizza, ma perde il suo significato, perché. l'uomo non esiste davvero.
In opposizione al monismo astratto, il pensatore propone il proprio atteggiamento filosofico e teologico, chiamato "monismo concreto". Il monismo concreto considera l'uomo e Dio essenzialmente uno:
“... la stessa essenza che è Dio è anche nell'uomo; e la stessa sostanza che è Dio sussiste anche nell'uomo. Dio risulta essere un profondo fondamento inconscio trascendentale dell'esistenza e della coscienza umana. Il filosofo chiama questo soggetto e sostanza trascendente dell'individualità umana Selbst ("sé"), in contrasto con il finito autocosciente I (Ich).
Poiché il Sé è necessariamente inerente al Sé, è anche identico a Dio. L'uomo individuale è un "gruppo di funzioni relativamente costante" radicato nella realtà divina.
E. von Hartmann ritiene che solo l'unità dell'essenza divina e umana rende possibile la fede e la grazia (3). Ma per la salvezza, fine ultimo della vita religiosa dell'uomo, non basta l'unità ontologica predeterminata dell'uomo e di Dio. L'uomo deve anche realizzare l'unità teleologica - fare coscientemente suoi gli obiettivi perseguiti da Dio. Deve mettere le inclinazioni naturali (naturali) al servizio della moralità e combattere quelle negative e distruttive. Senza l'unità ontologica con Dio, la salvezza dell'uomo sarebbe impossibile, ma può realizzarsi pienamente solo quando, grazie al fattore etico, il suo rapporto naturale con Dio diventa religioso. Il filosofo parla di «una nuova vita sacrificale e consacrata a Dio» (4).
Tuttavia, la salvezza è intesa da E. von Hartmann per niente in senso cristiano. A suo avviso, consiste nell'immergersi "nella profondità ontologica del vero sé" - nello spirito assoluto impersonale e inconscio. Tale salvezza deve in definitiva essere collegata alla morte fisica e all'annientamento dell'autocoscienza e dell'individualità.
Solo il monismo concreto può soddisfare entrambe le esigenze della coscienza religiosa: da un lato, il mondo è riconosciuto come realmente esistente, dall'altro, l'assolutezza di Dio non è limitata. La giustificazione della moralità, secondo von Hartmann, è possibile solo nel panteismo. Poiché tutti gli uomini sono uno, danneggiare gli altri è danneggiare se stessi, e il braminico tat tvam asi è incomparabilmente più profondo e vero dell'"amore fraterno" cristiano.
Sulla base di tali atteggiamenti religiosi e filosofici, E. von Hartmann cerca di delineare i contorni di una futura religione (non usa il termine "postcristiano"). Non cerca in alcun modo di crearlo lui stesso: del resto, «la scienza e i suoi rappresentanti per loro natura non sono in alcun modo idonei a contribuire direttamente alla creazione di nuove religioni». Ma, sulla base della sua analisi, sostiene che questa religione non sarà più cristiana, sebbene alcuni elementi del cristianesimo, in sostanza, i suoi resti, potranno integrarsi nella nuova dottrina. Il filosofo dubita fortemente che una nuova religione apparirà nel prossimo futuro: l'inerzia storico-religioso è ancora grande e le masse popolari non sono pronte per una rivoluzione religiosa. Ma anche quando saranno maturi, il processo di apparizione della religione sarà lungo: il vecchio deve estinguersi completamente e il nuovo deve maturare.
E. von Hartmann non esclude che "neoplasie religiose vitali" possano non comparire affatto, sebbene lo ritenga estremamente improbabile. Nonostante un notevole aumento alla fine del XIX secolo. sentimento ateo, non crede che la ragione e la scienza positiva potranno mai saturare completamente la coscienza popolare e spodestare da essa il bisogno religioso.
Tornando alla dottrina della religione del futuro, notiamo che E. von Hartmann credeva: più l'umanità si muove lungo la via del progresso tecnologico, più l'ottimismo ideologico sarà sostituito dal pessimismo e quando l'umanità avrà esaurito tutte le possibilità di sviluppo terreno, la questione dell'eliminazione delle sofferenze mondane diventerà la più importante di tutte.
E. von Hartmann vede l'essenza della nuova religione nella sintesi delle tradizioni religiose occidentali e orientali, del monoteismo e del panteismo. L'esclusivismo cristiano deve essere superato e le "fasi culturali" indiana ed europea si fondono in un unico flusso spirituale. È questo, secondo il pensatore, che darà senso alla storia del mondo.
La filosofia speculativa tedesca può promuovere il progresso nella sfera religiosa. Dovrebbe «fondere in un unico insieme sistematico le verità delle idee religiose intraasiatiche, frammentariamente comprese da Hegel, Schopenhauer (Fichte, Schelling, Herbart e altri), da un lato, con elementi cristiani conservati, e dall'altro, con il ventaglio di idee sviluppate dalla cultura moderna (e che trovano espressione, per la maggior parte, già in Hegel)".
Tuttavia, ci può essere giustamente posta la domanda: in che modo la filosofia della religione di Eduard von Hartmann risulta essere rilevante per il pensiero moderno? Dopotutto, le idee di questo pensatore, popolari alla fine del XIX secolo, si sono poi rivelate quasi dimenticate e i creatori di nuovi movimenti religiosi nel XX secolo hanno cercato a malapena di metterle in linea con il piano di Hartmann. A nostro avviso, l'importanza dello studio della filosofia della religione di E. von Hartmann è dettata dalla sua posizione e dal suo ruolo nella storia del pensiero idealistico tedesco.
Come è già chiaro dalla narrazione, l'insegnamento di Hartmann si è formato sulla base di precedenti sistemi idealisti: Schelling, Hegel e Schopenhauer. Allo stesso tempo, a nostro avviso, concettualmente e tematicamente, rivela il rapporto più stretto con la filosofia del compianto (dopo il 1809) F. Schelling. Quindi, in entrambi gli insegnamenti, l'idea chiave è l'autocoscienza dell'Assoluto, e ad esso, e, quindi, all'emergere del mondo e dell'uomo, due principi ontologicamente interconnessi e interagenti nascosti nell'Assoluto guida: attivo e passivo . Per Schelling, questo è "ciò che può essere" e "puramente esistente", mentre per von Hartmann è volontà e rappresentazione.
A Schelling si fa riferimento anche dall'affermazione di von Hartmann che "il conflitto che produce la coscienza non può essere puramente ideale e puramente logico ... può verificarsi solo quando l'idea logica ha guardato fuori (hinausgeschaut hat) se stessa nel suo opposto". L'opposto dell'ideale è la realtà della volontà, perché «da un puramente ed esclusivamente ragionevole
È impossibile dedurre una volontà da questo principio del mondo e, quindi, spiegare la coscienza. I pensieri di Schelling sono chiaramente la fonte di questa idea: von Hartmann riprende le sue affermazioni sull'insufficienza dell'approccio razionalistico. Anche Rodnit Schelling e von Hartmann fanno appello al metodo induttivo.
Anche il "culmine" della filosofia di Hartmann - il pessimismo della visione del mondo - risulta essere un prestito da Schelling. Così, nelle "Epoche del mondo", il filosofo sosteneva che la natura divina lasciata a se stessa (cioè Dio che non si è realizzato) conduce "una vita di abominio e paura", sta "divorando continuamente e di nuovo riproducendo incessantemente il fuoco stesso" . Una buona rinascita della natura è possibile solo attraverso l'azione dello spirito divino, cioè il risultato dell'autorealizzazione di Dio in una persona, in qualche modo (debolmente marcato) connesso con il ritorno di Dio allo stato originale.
In The Ages of the World, Schelling esprime una visione del fine ultimo dell'essere che è molto vicina a quella di Hartmann: “La libertà, o la volontà che in realtà non desidera nulla, è il concetto affermativo dell'eternità incondizionata, che noi, al di fuori di ogni tempo , può immaginare solo come immobilità eterna. Tutto intorno a lei desidera ardentemente lei e desidera ardentemente lei. L'unico obiettivo di ogni movimento è l'immobilità eterna, e tutto il tempo, compreso l'eterno, non è altro che una costante sete di eternità. Tutto si calma solo quando trova la propria essenza, sostegno e costanza nella volontà che non vuole nulla. Il vero scopo del più grande tumulto della vita e del movimento più turbolento di tutte le forze è sempre una volontà che non vuole nulla. Ogni creatura, e soprattutto l'uomo, si sforza esclusivamente di ritornare allo stato di nulla-non-volitività (Nichtswollen)...».
Le somiglianze che abbiamo citato sono sufficienti per considerare il pensiero di Hartmann un diretto successore del pensiero di Schelling. In questo aspetto, la filosofia della religione di von Hartmann gioca un ruolo cruciale: mostra come la dottrina del futuro della religione e della religiosità possa essere costruita a partire dalle posizioni speculative dell'idealismo post-kantiano.
Si noti che per una serie di ragioni, né Schelling né Hegel toccano esplicitamente questi problemi. In primo luogo, l'audace critica della teologia di Hartmann molto probabilmente non sarebbe passata senza conseguenze per le loro carriere, e in secondo luogo, difficilmente avrebbero potuto essere così critici nei confronti del cristianesimo, perché lo stesso Schelling, almeno negli ultimi quarant'anni della sua vita, ha cercato di avvicinare la sua filosofia alle disposizioni più importanti della teologia cristiana. La filosofia della religione di von Hartmann completa l'incompletezza delle costruzioni degli idealisti post-kantiani, i quali, prestando grande attenzione al problema della conoscenza di Dio, non hanno sviluppato né proposto un progetto religioso, nonostante la portata speculativa e la profondità ideologica del loro il lavoro ha contribuito molto a questo.
La dottrina di Hartmann sulla religione futura integra i pensieri di numerosi filosofi precedenti. La critica al teismo ci ricorda J.G. Fichte, e il desiderio di "ributtarsi nel Brahman come una bolla nell'oceano, svanire come luce nel vento e non rinascere" e l'idea dell'inevitabilità del passaggio al panteismo riguardano anche Schelling e Schopenhauer .
Il progetto del panteismo di Hartmann - "monismo spiritualistico", alias "monismo panteistico", alias "monoteismo immanente impersonale" - mostra quali caratteristiche potrebbe avere il trasferimento delle costruzioni degli idealisti tedeschi nella pratica religiosa. Qui sta il suo valore e interesse.
APPUNTI
(1) Si noti che la tarda filosofia di Schelling è percepita da von Hartmann come una sintesi simile già avvenuta - V.Z.
(2) Gli insegnamenti di E. von Hartmann sull'evoluzione delle idee teologiche, ovviamente, non possono essere considerati oggi come una fonte scientifica sull'argomento in questione. Alla fine del secolo scorso, lo studio delle religioni primitive era appena iniziato. Questa costruzione speculativa di E. von Hartmann ci interessa nel contesto della conferma della sua posizione religiosa e filosofica.
(3) In questo articolo omettiamo la spiegazione del concetto di "grazia" di Hartmann. Diciamo solo che svolge in larga misura il ruolo di un costrutto speculativo che media il rapporto tra Dio e l'uomo nel sistema di Hartmann.
(4) È ovvio che, nonostante la sua opposizione tra religione e filosofia religiosa e il suo atteggiamento pessimista, Eduard von Hartmann continua la tradizione etica di Kant e Fichte.
LETTERATURA
Falkenberg R. La storia della nuova filosofia da Nicola da Cusa (XV secolo) ad oggi. San Pietroburgo, tipografia I.N. Skorochodova, 1894.
Hartmann A. von. Eduard von Hartmanns konkreter Monismus // Drews A. (Hrsg.) Der Monismus dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter. Bd 2. Historisches. Jena: Eugen Diederichs, 1908.
Hartmann E. von. La filosofia positiva di Schelling als Einheit von Hegel und Schopenhauer, Berlino: O. Loewenstein, 1869.
Hartmann E. von. Philosophie des Unbewussten. 2 Aufl. Berlino: Verlag di Carl Duncker, 1870.
Hartmann E. von. Die Selbstzersetzung des Christentums oder die Religion der Zukunft. Berlino: Verlag di Carl Duncker, 1874.
Hartmann E. von. Erläuterungen zur Metaphysik des Unbewussten mit besonderer Rücksicht auf den Panlogismus. Berlino: Verlag di C. Duncker, 1874.
Hartmann E. von. Religione dei Geistes. Berlino: Verlag di Carl Duncker, 1882.
FWJ Schellings sämmtliche Werke. Stoccarda e Augusta, 1861 Abth. 1, b. 10 (SWX).
DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-1-7-16
EDUARD VON HARTMANN: RELIGIONE POSTCRISTIANA E IDEALISMO TEDESCO
Istituto di Filosofia e Studi Sociali e Politici Università Federale Meridionale
Bolshaya Sadovaya Str., 105, Rostov sul Don, Russia, 344006
astratto. Questo articolo è dedicato alla considerazione della filosofia della religione di Eduard von Hartmann. L'autore esamina il suo critico della teologia liberale. E.v. Hartmann pensa che la religione cristiana stia morendo. L'umanità allo stesso tempo ha bisogno della religione. Quindi il problema della religione post-cristiana è posto come legittimo e importante argomento di discussione.
L'articolo mostra che, secondo E.v.Hartmann, l'unica prospettiva mondiale in grado di soddisfare l'anelito spirituale umano nel futuro è il monismo concreto. Insegna che l'Assoluto è inconscio. Il vero fondamento trascendente dell'uomo è l'inconscio secondo Sé (Assoluto).Lo scopo finale della vita consiste nella salvezza cioè la dissoluzione con la morte fisica nella profondità ontologica del Sé. La religione del futuro è vista da E.v. Hartmann nella sintesi di Orientale (indiano) e Le correnti spirituali occidentali Secondo l'opinione del filosofo, l'idealismo speculativo tedesco deve favorire questa sintesi.
La teoria di E.v.Hartmann è una forma originale del misticismo che evita l'acosmismo e riconosce incondizionatamente l'incoscienza dell'Assoluto. L'analisi storica consente di includere la filosofia di E.v.Hartmann nella tradizione metafisica tedesca del XIX secolo.
L'autore dimostra brevemente la notevole vicinanza delle idee di E. v. Hartmann alla successiva filosofia di F. Schelling. Conclude che la dottrina della futura religione di E. v. Hartmann è molto importante per la storia della filosofia perché potrebbe essere considerata come l'unico progetto religioso costruito sulla base dell'idealismo tedesco in comune e del pensiero di Schelling in particolare.
Parole chiave: E. von Hartmann, F. Schelling, Dio, religione del futuro, cristianesimo, Inconscio, pessimismo
Falckenberg R. Istoriya novoy filosofii ot Nikolaya Kuzanskogo (XV v.) do nastoyaschego vremeni. . San Pietroburgo: Tipografiia I.N. Skorochodova, 1894.
Halpern I. (Hrsg.) Schleiermachers Dialektik. Berlino: Mayer & Müller, 1903.
Von Hartmann A. Eduard von Hartmanns konkreter Monismus. Drews A. (Hrsg.) Der Monismus dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter. bd. 2. Storico. Jena: Eugen Diederichs, 1908.
La filosofia positiva di Von Hartmann E. Schelling als Einheit von Hegel und Schopenhauer, Berlino: O. Loewenstein, 1869.
Von Hartmann E. Philosophie des Unbewussten. 2 Aufl. Berlino: Verlag di Carl Duncker, 1870.
Von Hartmann E. Die Selbstzersetzung des Christentums oder die Religion der Zukunft. Berlino: Verlag di Carl Duncker, 1874
Von Hartmann E. Erläuterungen zur Metaphysik des Unbewussten mit besonderer Rücksicht auf den Panlogismus. Berlino: Verlag di C. Duncker, 1874.
Von Hartmann E. Religion des Geistes. Berlino: Verlag di Carl Duncker, 1882.
FWJ Schellings sämmtliche Werke. Stuttgart und Augsburg, Cotta "scher Verlag, 1861, Abth. 1, Bd. 10 (SW X).
Schneider A. Personalität und Wirklichkeit. Würzburg: Verlag Konigshausen & Neumann GmbH, 2001.
Wolf J.-C. Eduard von Hartmann - ein Philosoph der Gründerzeit. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 2006.
Eduard von Hartmann. L'essenza del processo mondiale, o la Filosofia dell'Inconscio / Per. con lui. A. Kozlov.
T. I. Inconscio nei fenomeni della vita corporea e spirituale. T. II. Metafisica dell'inconscio. ed. 2°, corretto.
- M.: KRASAND, 2010. - 322 + 440 p.
Eduard von Hartmann (1842–1896) era un filosofo tedesco un tempo famigerato, ma oggi semidimenticato e sottovalutato. Può essere considerato l'ultimo dei grandi polistori in senso antico o medievale, cioè pensatori che hanno cercato di catturare ed elaborare all'interno del loro sistema quasi l'intero corpus del sapere contemporaneo. Già all'inizio del XX secolo, l'emergere di tali personalità titaniche e sistemi filosofici monumentali divenne impossibile a causa di un aumento simile a una valanga della quantità di informazioni e di una paralizzante iperspecializzazione.
La tanto attesa ristampa dell'opera principale di Eduard von Hartmann è un regalo per tutti gli intenditori di filosofia. Ad essere onesti, la parola "corretto" nell'output è fuorviante. Entrambi i volumi sono del tutto identici alla prima edizione (M., 1873-1876). Gli editori erano troppo pigri per portare l'ortografia pre-riforma allo standard moderno, non modificavano il testo, correggevano errori di battitura, scrivevano commenti, ma creavano un layout da immagini scansionate.
Certo, si può dire che la prima edizione del libro di Hartmann nella traduzione "quasi esatta" del filosofo russo Alexei Alexandrovich Kozlov (1831-1901) è un monumento storico e culturale, la cui ristampa nella sua forma intatta è giustificata in se stesso. Tuttavia, vorrei sperare che la "Filosofia dell'inconscio", e tutte le altre opere principali di Eduard von Hartmann (e le opere complete del filosofo hanno circa 40 volumi), un giorno saranno pubblicate in russo in una traduzione esatta , nell'ortografia moderna, con il relativo apparato scientifico e commenti.
Nel nostro breve saggio, ovviamente, non saremo in grado di dare un'idea generale della scala e della profondità delle costruzioni di Hartmann. Il nostro obiettivo è interessare il lettore a questo incantevole pensatore. E per questo, ci rivolgiamo a uno degli argomenti metafisici più originali di Hartmann, che, se lo si desidera, può essere considerato come una rivelazione sorprendente, o come un esperimento mentale, un paradosso ingegnoso o addirittura un sofisma. Questo argomento, presentato nella sezione conclusiva del secondo volume de La filosofia dell'inconscio (cap. XIII. Ultimi inizi), chiameremo "Il limite di Eduard von Hartmann".
Annichilismo
La filosofia dell'inconscio è stata scritta dal filosofo 26enne Eduard von Hartmann, e il suo stile impeccabile ("Schopenhauer"), il linguaggio ricco e, naturalmente, l'originalità del metodo e dei contenuti hanno giocato un ruolo significativo nella sua successo. L'autore pretendeva di completare la linea "classica" della filosofia tedesca, o meglio, di sintetizzarne i due rami principali: Kant - Fichte - Schelling - (Hegel, Schopenhauer). Ma il lettore attento scoprirà che, nonostante si sforza di mantenere una linea di mezzo tra Hegel e Schopenhauer, Hartmann gravita più verso Francoforte che verso il pensatore berlinese, e non solo stilisticamente.
L'orientamento ideologico generale di Schopenhauer e Hartmann può essere chiamato "pessimismo assoluto". Tuttavia, anche tra i pessimisti più coerenti e radicali, ben pochi hanno sviluppato le idee dell'autodistruzione cosmica universale, dell'autodistruzione del mondo, dell'ontocidio. Pertanto, ci sembra che Schopenhauer e Hartmann (così come il filosofo tedesco Philip Mainländer, a loro correlato) dovrebbero essere individuati in un gruppo separato di "annichilisti".
Cos'è l'annichilismo? Ci proponiamo di intendere con questo neologismo la dottrina della preferenza per la non esistenza del mondo rispetto alla sua esistenza, l'opportunità di fermare il "processo mondiale" e modalità specifiche per portare il mondo in uno stato di non esistenza. La possibilità di un'abolizione intenzionale del mondo è stata motivata per la prima volta da Schopenhauer nell'ambito del suo sistema. Se, ad esempio, Buddha parlava solo di salvezza personale, allora la novità dell'insegnamento di Schopenhauer consisteva nel fatto che la possibilità di distruzione (o autodistruzione) della fondazione metafisica del mondo - la volontà (analoga a Brahman), " questo mostro" è stato affermato.
Poiché la base metafisica del mondo, secondo Schopenhauer, è la volontà del mondo (è anche la volontà di vivere), allora un atto volitivo di negazione del mondo (negazione della vita) è sufficiente per abolire il mondo. Il completo calmare (dimissioni) della volontà in un individuo, poiché la volontà nella sua essenza è una, significherebbe la morte della volontà in generale. Un atto mistico di assoluta negazione della vita può liberare il mondo intero dal peso dell'esistenza. Tutto accadrebbe come se la volontà, vedendosi nello specchio della coscienza di una sua manifestazione, rabbrividisse di orrore e, convinta che il mondo da essa creato è irrimediabilmente cattivo, arrivasse alla negazione di sé e alla pace eterna in volontaria immersione nel nulla.
Un tale filo di pensiero, ovviamente, ha portato a un vicolo cieco. Schopenhauer ha descritto con entusiasmo le gesta dei grandi asceti del passato, il cui esempio ha esortato a imitare, tuttavia, trovando difficile spiegare in modo comprensibile perché, dopo tanti atti eroici di negazione del mondo e della vita, l'Universo esiste ancora.
Per superare questa difficoltà, Schopenhauer prevedeva che il compito di distruggere il mondo poteva essere raggiunto con più successo sulla via dello sforzo collettivo. Credeva che il Nuovo Testamento della non procreazione dovesse sostituire il comandamento dell'Antico Testamento della riproduzione. Questo è ciò che il mondo anelito alla non esistenza si aspetta su questo cammino: “Se questa massima (rifiuto di avere figli) diventa universale, allora il genere umano cesserà. Insieme all'uomo, in virtù della connessione che esiste tra tutte le manifestazioni della volontà, scomparirà anche il mondo degli animali: così la piena luce proietta la penombra. Con il completo annientamento della cognizione, il resto del mondo si trasformerebbe nel nulla, poiché senza soggetto non c'è oggetto ”(“Il mondo come volontà e rappresentazione”, Vol. I, paragrafo 68).
processo mondiale
Hartmann migliorò significativamente il sistema di Schopenhauer. Secondo Hartmann, la base metafisica del mondo è l'Inconscio con due attributi (nel senso di Spinoza) - volontà e rappresentazione, motivo per cui lo chiama anche "volontà rappresentativa". Il lieto fine del processo mondiale è lo stesso di Schopenhauer: l'abolizione ("redenzione") del mondo.
Inizialmente, la volontà era in uno stato di pura potenza (o non esistenza), e l'idea era in uno stato che Hartmann designa in diversi modi: pura possibilità, superesistente, essere nascosto. La volontà volle volere in modo assolutamente accidentale e insensato e passò dalla potenza all'atto. L'essere reale, che deve la sua esistenza alla follia della volontà, si distingue per il carattere di irragionevolezza e insensatezza: c'è qualcosa che non dovrebbe essere. Hartmann era d'accordo con Schopenhauer: l'esistenza del mondo nel suo insieme contiene più sofferenza che piacere, e, di conseguenza, la non esistenza del mondo è preferibile alla sua esistenza. Ma la coscienza non può ridurre e distruggere direttamente la volontà, può solo suscitare una volontà opposta, quindi negativa. Quando la volontà opposta motivata dalla coscienza diventa uguale in forza alla volontà del mondo di essere distrutta, si paralizzeranno completamente a vicenda e si trasformeranno in zero, cioè si distruggeranno a vicenda senza lasciare traccia.
Ma come iniziare a distruggere il mondo in pratica? La negazione ascetica della volontà, secondo Hartmann, è altrettanto assurda e senza scopo, o anche più assurdo, del suicidio, poiché il primo realizza solo più lentamente e dolorosamente ciò che il secondo realizza: cioè la cessazione di un fenomeno concreto senza intaccare la sua essenza. Pertanto, il desiderio di una negazione individuale della volontà è un'illusione, ma un'illusione solo in relazione al percorso e non in relazione alla meta. Non porta all'obiettivo desiderato e al rifiuto generale della gravidanza: «A cosa servirebbe, ad esempio, il fatto che l'umanità si estinguesse per astinenza sessuale, e che il mondo infelice continuasse la sua esistenza: di conseguenza, risulterebbe che l'Inconscio dovrebbe cogliere la prima occasione per crea una nuova persona o un tipo simile, e tutta la storia di gemiti e dolori ricomincia da capo.<...>Per chi sta fermamente sull'unità dell'Inconscio, la salvezza, il passaggio della volizione nella non volizione è concepibile solo come atto universale, non come individuo, ma come negazione cosmica-universale della volontà, come ultimo momento, dopo di che non ci sarà volontà, nessuna attività.(II, pp. 372–373). Ci deve essere una tale coordinazione e velocità di comunicazione tra gli abitanti del globo che possono simultaneamente portare a termine la loro negazione della volontà e superare la quantità di volontà positiva che si manifesta nel mondo inconscio.
È possibile in linea di principio un simile epilogo del dramma mondiale? Il più anziano Schopenhaueriano (apprezzato da Hartmann) Julius Banzen (1830–1881) pensava di no. Per lui la volontà è inquieta, l'esistenza del mondo è un male irrevocabile e irreparabile: "Un momento in sé è minuscolo, ma più forte dell'abnegazione di tutti i tempi". Hartmann sostiene: “Se questa vittoria fosse impossibile, se questo processo non fosse uno sviluppo verso un obiettivo pacifico; se fosse infinito ed esaurito solo dalla cieca necessità e dal caso, senza presentare alcuna possibilità di una conclusione positiva, allora, ovviamente, allora e solo allora il mondo rappresenterebbe qualcosa di assolutamente senza speranza, sarebbe un inferno senza esito; e la stupida abnegazione sarebbe l'unica filosofia possibile. Ma noi, che riconosciamo nella natura e nella storia il maestoso e meraviglioso processo di sviluppo, crediamo nella vittoria finale della ragione sempre più luminosa e luminosa sulla follia della volontà cieca, crediamo nella fine del processo, che ci porta la salvezza da il tormento dell'essere, il fine, per l'accelerazione di cui possiamo fare la nostra parte se siamo guidati dalla ragione.(II, pp. 369–370).
Limita l'argomento
Tutto questo è meraviglioso a modo suo, ma sorge una domanda che non ha disturbato Schopenhauer in una forma così acuta. Se il mondo può essere riportato al suo stato originario, dal quale un tempo era stato fatto uscire dalla volontà, allora dov'è la garanzia che la clessidra dell'essere non torni più? La volontà come potenza, che può decidere di esistere o meno, è assolutamente libera: né dall'esterno, né dall'interno, la sua libertà non è limitata da nulla. Pertanto, la potenza della volontà può nuovamente decidere di volere e, di conseguenza, esiste la possibilità che il processo mondiale si svolga tutte le volte che si desidera nello stesso ordine. Sembrerebbe che non ci possa essere certezza in questa materia ...
E qui inizia il più interessante (II, pp. 398-399). Hartmann propone un semplice calcolo che permette di stimare la probabilità che la volontà, dopo diversi atti di volere e di autonegazione, decida di volere ancora. Poiché la volontà è assolutamente libera nella sua scelta (decidere se volere o non volere), la probabilità di ciascuna delle due possibilità è 1/2 (come nel lancio di una monetina). Se teniamo conto che con la fine del processo mondiale si ferma anche il tempo, allora la materia può essere immaginata come segue: la potenza al momento dell'annientamento delle conseguenze del suo atto precedente decide di nuovo di agire. Poiché la probabilità di un evento futuro in questo caso non può essere influenzata dal passato, il coefficiente di probabilità 1/2 per la prossima emergenza del desiderio dalla potenza rimarrà lo stesso.
Ora possiamo stimare la probabilità a priori che l'uscita del desiderio (e con esso il processo mondiale) dalla potenza si ripeta n volte. Ovviamente, questa probabilità sarà la stessa della probabilità di lanciare una moneta testa n volte di seguito, cioè pari a (1/2) n . All'aumentare di n, diventa arbitrariamente piccolo, così che la probabilità che la volontà esca più volte di potenza è piccola. Di conseguenza, prima o poi, l'esistenza dovrà stabilirsi nella sacra pace del nulla: lim (1/2) n = 0 poiché n tende all'infinito. In realtà, questo è il limite di Eduard von Hartmann.
L'umanità sarà in grado di affrontare adeguatamente la distruzione dell'universo? Naturalmente, questo non si può dire con certezza, e Hartmann esclama stoicamente: "Se l'umanità sarà capace di un tale innalzamento della coscienza per raggiungere l'obiettivo, o se un'altra specie superiore sorgerà sulla Terra per questo, o se l'obiettivo sarà raggiunto in condizioni più favorevoli su un altro corpo celeste, è difficile dire. Comunque sia, nel mondo a noi noto, siamo i primogeniti dello spirito e dobbiamo combattere onestamente.(II, p. 373).
Confutazioni
Si può immaginare che tipo di reazione abbia suscitato il progetto apocalittico proposto da Eduard von Hartmann. Friedrich Nietzsche dedicò ad Hartmann (non tanto una confutazione quanto un ridicolo) la seconda delle Untimely Meditations, On the Benefits and Harms of History for Life (1874), in cui gli fece dubbi dubbi come il primo "filosofo parodista" in cui «è giunta l'ora di assumere un atteggiamento ironico verso se stessi» (af. 9). In "Human, Too Human" (af. 357), suggerì ancora una volta che Hartmann stesse solo "scherzando". Ha scherzato senza successo, ovviamente, Nietzsche. È improbabile che Hartmann, in cui tutto (sia la biografia che il modo di espressione) espone un pensatore nobile e onesto, fosse capace di un tale umorismo mefistofelico. Eugene Dühring credeva che "la fine del mondo progettata da Hartmann, per mezzo di una decisione presa dalla maggior parte dell'umanità, supera tutti i fenomeni del normale disturbo cerebrale".
D'altra parte, si può dire che nella filosofia russa fu il sistema Hartmann a risvegliare una delle menti più straordinarie: Vladimir Sergeevich Solovyov, che dedicò la sua tesi di master "La crisi della filosofia occidentale (contro i positivisti)" (1874 ) alla confutazione del sistema Hartmann (compreso il suo argomento "ultimo").
In generale, quando si tratta di come qualcosa può trasformarsi in un nulla assoluto e viceversa, tutti gli annichilisti sono insopportabilmente oscuri. Solovyov ha colto il "tallone d'Achille" dell'annichilismo, mascherato con cura ma senza successo in La filosofia dell'inconscio. Secondo Hartmann, la volontà era originariamente in uno stato di pura potenza, o di puro non essere, ma il puro non essere (anche se si postula la sua identità con il puro essere, come fece Hegel) non può passare nell'essere attuale. Solo il concetto di non essere passa nel concetto di essere e viceversa, come mostra Hegel, ma il concetto di non essere non è niente, cioè il concetto. Cioè, sostiene Solovyov, avendo posto la pura non esistenza come inizio assoluto, sarebbe necessario fermarsi a questo inizio. Hartmann commette un errore logico: “pensa alla volontà e alla rappresentazione come esistenti in uno stato di potenza prima della loro esistenza effettiva, pensa alla potenza pura, esistente in sé, al di fuori dell'attualità, cioè ipostatizza il concetto astratto di potenza, nonostante la natura completamente relativa di questo concetto” (Vladimir Solovyov, Dispute on Justice, Mosca, 1999. 391 pp.).
Possiamo tranquillamente presumere che Solovyov abbia ereditato da Hartmann la scala del pensiero, la portata metafisica del suo stesso progetto. La gratitudine del filosofo russo si è manifestata anche nel fatto che ha sottolineato il significato positivo del sistema di Hartmann non solo per il proprio sviluppo ideologico, ma anche per il pensiero europeo nel suo insieme.
In conclusione, vorremmo dare la parola allo stesso Vladimir Solovyov. Ci scusiamo per il volume delle citazioni, ma sono più eloquenti di qualsiasi rivisitazione. “La verità della filosofia pratica di Hartmann sta, in primo luogo, nel riconoscimento che il bene supremo, il fine ultimo della vita, non è contenuto negli oggetti di una data realtà, nel mondo della realtà ultima, ma, al contrario, è raggiunto solo attraverso la distruzione di questo mondo e, in secondo luogo, nel riconoscere che quest'ultimo traguardo è realizzabile non per un individuo nel suo individuo, ma solo per l'intero mondo degli esseri, sicché tale raggiungimento è necessariamente condizionato dal corso di sviluppo mondiale generale ”(Ibid, p. 431).
“D'altra parte, è chiaro che quando Hartmann, dopo aver mostrato in modo abbastanza completo il carattere negativo del processo mondiale e il suo risultato finale, o obiettivo, afferma che in questo risultato finale non solo la realtà effettiva del mondo reale finito nella sua viene rimossa l'autoaffermazione esclusiva (come è indubbiamente vero), ma che questo è un perfetto annientamento, un passaggio alla pura non esistenza, è chiaro che tale affermazione non è solo assurda di per sé (come abbiamo mostrato prima), ma contraddice anche direttamente il principale principio metafisico dello stesso Hartmann. Infatti, la fine del processo mondiale, in primo luogo, non può essere l'annientamento incondizionato di tutto ciò che esiste, perché, in fondo, lo spirito assoluto, tutto uno, che è completamente svincolato dal tempo (come ammette anche Hartmann), non può in sé essere determinato dal processo mondiale temporaneo, di conseguenza esso rimane immutato nel suo essere assoluto sia prima del processo mondiale, sia durante esso e dopo di esso, quindi questo processo e il suo risultato finale sono significativi solo per l'essere fenomenologico, per il mondo di fenomeni reali. Ma, in secondo luogo, anche per questo mondo la fine del processo non è l'annientamento in senso incondizionato» (Ibid, pp. 431-432).
“Il fine ultimo e il bene supremo sono raggiunti solo dalla totalità degli esseri attraverso il corso necessario e assolutamente opportuno dello sviluppo mondiale, il cui fine è la distruzione dell'autoaffermazione esclusiva degli esseri particolari nella loro discordia materiale e la loro restaurazione come un regno di spiriti abbracciati dall'universalità dello spirito assoluto» (Ibid, p. 433) .